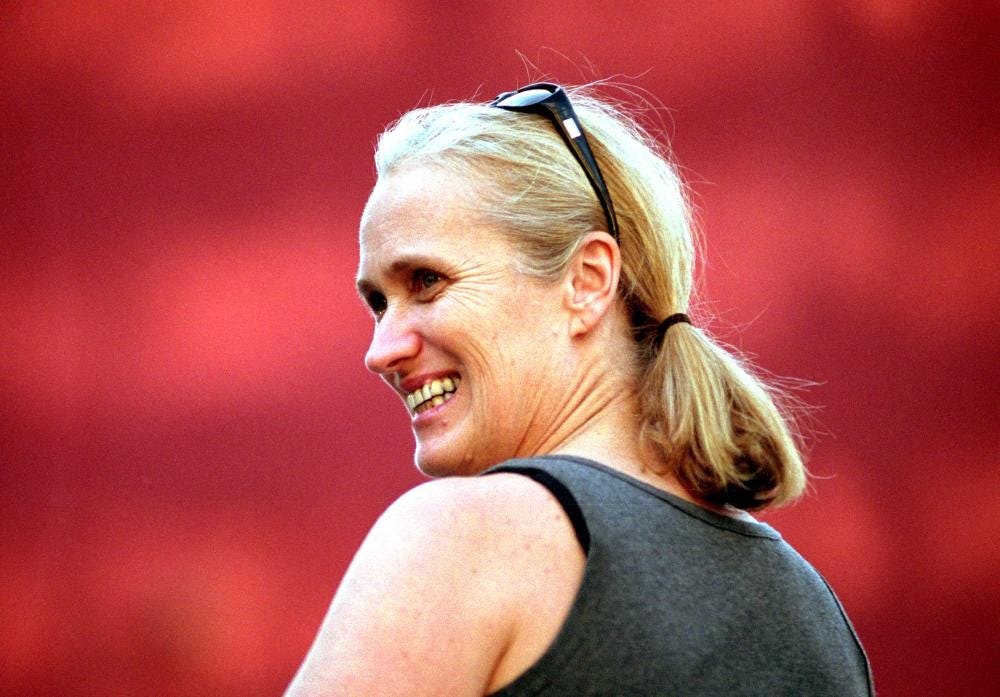Singolare, femminile ♀ #166: Il 3,5 per cento
Con la nomination per The Substance, Coralie Fargeat è diventata la nona donna in tutta la storia degli Oscar a ottenere una candidatura per la regia: ripercorriamo i profili e le carriere di queste “magnifiche 9”, ricordando che sono solo la punta di un iceberg di cinema femminile che l’Academy pare abilissima a schivare.
9 in 97 anni: vuol dire una ogni quasi 11 anni, e sono in proporzione quasi 30 volte meno rispetto al numero dei colleghi maschi (che ammonta a 248). Il 3,5%, appunto.
Parliamo delle registe che, nel corso della storia degli Academy Award, hanno ottenuto una nomination all’Oscar per la migliore regia; l’ultima in ordine cronologico è la francese Coralie Fargeat, candidata per The Substance, che gareggia anche per il miglior film (il verdetto lo scopriremo la notte tra il 2 e il 3 marzo). Una sproporzione che amplifica in modo esponenziale il divario di maestranze femminili nell’industria cinematografica di cui ci siamo già più volte occupate: potremmo anche affermare che, in fondo, degli Oscar poco ci importa; che le nomination, la cerimonia e le statuette sono - da sempre - una fotografia deformata e insufficiente dell’anno cinematografico che suggellano, e che ne restano costantemente tagliati fuori titoli e nomi cruciali (gli esempi classici: un Oscar non l’hanno mai vinto Chaplin, né Hitchcock, né Kubrick), certo. Ma la questione, come spesso ribadiamo, è di visibilità: le poche dozzine di titoli che ogni anno vengono portate alla ribalta da quello che è convenzionalmente considerato il più prestigioso premio cinematografico al mondo godono di una vetrina che rende i loro titoli noti alle masse, eternati da un simbolico timbro di garanzia che fa entrare “nella storia del cinema” (la storia ufficiale e mainstream, almeno).
Il fatto, allora, che per quasi mezzo secolo non ci sia stata alcuna regista candidata all’Oscar (il premio nasce nel 1929, la prima è Lina Wertmüller nel 1977) è assai emblematico della scarsa visibilità in cui sono state a lungo relegate le donne dietro la macchina da presa, così come è significativo che le cose stiano cambiando con accelerazioni differenti da vent’anni a questa parte: di 10 nomination totali per le registe (Jane Campion la ha avuta due volte), otto sono giunte nel secolo corrente, e sei sono arrivate post #MeToo, a rimarcare delle svolte piuttosto incisive nell’immaginario e nell’approccio all’inclusività. Parte di questi cambiamenti sono in realtà legati alla piccola rivoluzione sollecitata dal movimento OscarsSoWhite, che nel 2016 denunciò la scarsissima diversità di etnie tra i candidati, portando a un’apertura dell’Academy che in un decennio ha fatto aumentare di circa 10 punti percentuali sia le votanti donne, sia i votanti appartenenti a minoranze etniche. Decisamente meno incisivi i tanto vituperati nuovi standard per l’inclusività, varati dall’Academy nel 2020 e in vigore a partire dalla scorsa edizione: indicate da più parti come una delle cause della presunta morte del cinema come arte, queste norme - che indicano una percentuale minima di minoranze tra le maestranze dei film eleggibili all’Oscar - sono in realtà strutturate per lasciare più o meno tutto come già è, con delle soglie di accesso facilmente affrontabili anche dai film candidati nei 95 anni precedenti, come spiegava bene già all’epoca questo articolo di "Il Post".
In questa newsletter ci occupiamo dei nomi delle nove donne candidate, ma qui vi forniamo un altro dato sintetico; nelle 97 edizioni degli Oscar sono 611 i titoli nominati come miglior film, dei quali solo 22 sono diretti da donne (di nuovo, quasi esattamente, la stessa percentuale: il 3,6%). Il 2024 è stato un anno da record, con ben 3 su 10 titoli candidati diretti da donne (Anatomia di una caduta di Justine Triet, Past Lives di Celine Song, Barbie di Greta Gerwig). Di alcuni di questi 22 film vi parliamo nei profili a seguire, perché erano candidati a miglior film oltre che a migliore regista.
Per quanto riguarda gli altri: per il primo film diretto da una donna a entrare nella fatidica cinquina bisogna aspettare addirittura il 1986, con Figli di un dio minore di Randa Haines (non lo vinse, ma vinse Marlee Matlin; all’epoca, a 21 anni, la più giovane miglior attrice di sempre, nonché la prima persona sorda a vincere un Oscar - 35 anni dopo, sarebbe stata protagonista del vincitore come miglior film CODA - I segni del cuore, diretto dalla regista Sian Heder). Seguono: Risvegli di Penny Marshall, Il principe delle maree di Barbra Streisand (che per inciso è stata la prima donna a vincere il Golden Globe per la regia, con Yentl), Little Miss Sunshine di Valerie Faris e Jonathan Dayton, An Education di Lone Scherfig, I ragazzi stanno bene di Lisa Cholodenko, Un gelido inverno di Debra Granik, Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, Selma - La strada per la libertà di Ava DuVernay, Piccole donne di Greta Gerwig, Women Talking di Sarah Polley (premiata poi solo per la migliore sceneggiatura: uno schema reiterato, come vedremo tra poco).
Difficile affermare che proprio questi siano i film in assoluto più importanti diretti da donne in quel lasso di tempo, a riprova dell’istantanea incompleta che gli Oscar offrono; ma anche a riprova del fatto che di film diretti da registe ce ne sono tanti, tanti di più, e che la battaglia per la visibilità e la parità passa anche da cerimonie un po’ frivole e vetuste come la Notte delle stelle.
LINA WERTMÜLLER
candidata nel 1977 per Pasqualino Settebellezze
È italiana (romana, con cognome esotico di lontane origini svizzere) la prima donna nella Storia a ricevere una nomination come migliore regista. Per il cinema nostrano, una vera e propria icona, tra le pochissime donne dietro la macchina da presa in decenni (quelli tra i 50 e i 70) dove le cineaste si contano sulle dita di una mano (Wertmüller, Cecilia Mangini, Liliana Cavani sono tra i nomi e i volti della sparuta e combattiva "quota rosa" del cinema italiano di quell'epoca). Quando Wertmüller arriva in cinquina con Pasqualino Settebellezze (il suo decimo di 22 lungometraggi), nel 1977, ha 49 anni e già quasi 25 di carriera, cominciata come segretaria di edizione e proseguita affiancando Fellini come assistente regista per La dolce vita e 8½, per poi lanciarsi in una filmografia che, dietro i celebri titoli lunghissimi (da Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto a Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica), è fatta di un impasto peculiare e personalissimo di grottesco, satira, denuncia sociale e tradizione popolare, dalla farsa al mélo. Un cinema slabbrato e vitale, paradossale e attentissimo alle maschere dei suoi fenomenali attori, su tutti la coppia Giancarlo Giannini-Mariangela Melato che regalano nei suoi film performance memorabili. Attiva fino all'inizio del terzo millennio, l'Oscar lo riceverà, infine, come premio alla carriera, nel 2020, un anno prima di lasciarci.
JANE CAMPION
candidata nel 1994 per Lezioni di piano e vincitrice nel 2022 per Il potere del cane
Nel 1993 Lezioni di piano è il primo film diretto da una donna a vincere la Palma d’oro al Festival di Cannes (comunque ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaige), in 46 edizioni (in Croisette Campion era già stata riconosciuta con il premio per il miglior corto, Peel, nel 1986). Amato dalla critica (con qualche illustre eccezione) e soprattutto dal pubblico, il film (di cui vi abbiamo parlato qui) arriva agli Oscar con otto nomination, tra cui miglior regia e miglior film, l’anno successivo, che però è quello di Schindler’s List e dell’inarrestabile apogeo di Spielberg. Campion inaugura tuttavia la (non dichiarata, ovviamente, ma ricorrente) “tradizione” dell’Academy di assegnare alle registe l’Oscar alla miglior sceneggiatura, quasi come “premio di consolazione” per la mancata regia - inoltre Lezioni di piano porta la statuetta anche alle sue attrici, la straordinaria Holly Hunter e la giovanissima Anna Paquin. Studiosa d’arte minimalista, con una gavetta nella televisione australiana, Campion s’impone come autrice fin dall’esordio Sweetie (subito in Concorso a Cannes) e dall’opera seconda Un angelo alla mia tavola (premiato a Venezia). Dopo l’exploit di Lezioni di piano, costruisce negli anni una filmografia non prolifica (Ritratto di signora, 1996, Holy Smoke, 1999, In the Cut, 2003, Bright Star, 2009, le due stagioni della serie Top of the Lake, 2013-2017), ma coerentissima nella sua indagine di femminilità non conformi, e nella sua capacità di restituire la fisicità e le oscurità dell’erotismo e della passione. Ed è nel 2021, con Il potere del cane (ne parlammo in questa newsletter), che raggiunge un record ancora “imbattuto” - la prima e unica donna finora a essere nominata per la regia due volte - e lo strameritato Oscar: con un western raggelato e tesissimo, che alla consueta esplorazione del femminile aggiunge quella di una maschilità fragile, sotto l’incombente peso di una natura monumentale. Nota: quell’anno l’Oscar al miglior film non va (sorprendentemente) a lei, ma a un altro film di una regista, CODA - I segni del cuore.
SOFIA COPPOLA
candidata nel 2004 per Lost in Translation - L’amore tradotto
Figlia d'arte, si emancipa presto dall'ombra del monumentale padre Francis Ford per dar vita a una carriera che rielabora incessantemente il tema della gabbia dorata in cui lei stessa è cresciuta, tra set e viaggi intercontinentali, con quel senso di privilegiata alienazione che spesso avviluppa le sue protagoniste. Proprio come la Scarlett Johansson di Lost in Translation, il film che le vale la nomination nel 2004 (a 33 anni: la più giovane tra le candidate di questo troppo breve elenco); e come la Marie Antoinette intrappolata nel languore vacuo di Versailles, o come Priscilla, moglie-bambina di Elvis nella reggia di Graceland. Il suo cinema ha segnato indelebilmente l'immaginario di inizio millennio, con colori pastello, colonne sonore cool e giovani donne alle prese con la propria costruzione identitaria, ma immerse in un vuoto esistenziale che attanaglia le sue "prigioniere" vergini suicide tanto quanto le cleptomani di Bling Ring. Nei suoi film esplora il prisma del femminile, ma anche l'inganno e l'eterno fascino della fama, raccontato con tenerezza e disillusione in Somewhere (il film che le vale il Leone d'oro a Venezia), e con intento ancor più iconoclasta in Priscilla; intesse complessi rapporti padre-figlia (di nuovo Somewhere, ma anche la bella e meno nota commedia On the Rocks); lavora sui corpi attoriali dei suoi feticci (Bill Murray, Kirsten Dunst) costruendo per loro circoli viziosi e "giri a vuoto" che imprimono sullo schermo lo spirito del XXI secolo. Vedi newsletter n. 106
KATHRYN BIGELOW
vincitrice nel 2010 per The Hurt Locker
«Il momento è giunto»: è Barbra Streisand, nel 2010, ad annunciare con emozione (e probabilmente una giusta dose di rancore, considerati i suoi trascorsi da regista nell’industria hollywoodiana) qualcosa che all’Academy non s’era mai visto, in 82 (ottantadue) edizioni. Ovvero un Oscar alla regia consegnato a un’autrice, Kathryn Bigelow, che con The Hurt Locker porta a casa anche il premio al miglior film e altre quattro statuette, stravincendo in un ideale confronto con l’Avatar dell’ex collaboratore e marito James Cameron. Regista (come lui) di “genere” fin dal meraviglioso esordio horror western Il buio si avvicina (1987) - e per questo spesso pigramente definita “maschile” dai commentatori -, maestra di costruzioni tensive e innovatrice di tecniche di ripresa (le soggettive di Point Break - Punto di rottura, 1991, e soprattutto Strange Days, 1995, di cui raccontammo qui), The Hurt Locker arriva alla fine di un decennio, gli anni zero, in cui la sua carriera sembrava in stallo critico e creativo: nella collaborazione con il giornalista Mark Boal (che firmerà la sceneggiatura anche del successivo, bellissimo, Zero Dark Thirty, nominato per il miglior film ma non per la regia), Bigelow affonda la macchina da presa nella Guerra al terrore, e nella sindrome da stress post traumatico di un’intera nazione. Il suo ultimo film, a oggi, è Detroit (2017), che la guerra a stelle e strisce se la ritrova in casa. Ci manca.
GRETA GERWIG
candidata nel 2018 per Lady Bird
La mancata nomination alla regia per Barbie, un anno fa, aveva scatenato una piccola sommossa tra fan e colleghi, anche se non era così imprevedibile considerata la generale avversione dell’Academy per la commedia, il cinema per ragazzi, il blockbuster in generale. Più bizzarra l’assenza di Gerwig nella cinquina dei registi del 2020, e abbastanza ingiusto (per chi scrive) che non abbia ricevuto il premio alla miglior sceneggiatura non originale per il suo Piccole donne, lavoro intelligente e sottile di trasposizione e aggiornamento di un grandissimo classico, con una direzione d’attrici impeccabile. Ma nel ristretto club di candidate alla regia, Gerwig ci era entrata già col suo esordio in solitaria, Lady Bird, coming of age d’ispirazione autobiografica, ambientato a inizio millennio e girato nella sua Sacramento; una confezione e una struttura da “Sundance movie”, ma con lo sguardo e l’attenzione già focalizzato sulle relazioni femminili davvero fondative nell’adolescenza, quella tra migliori amiche (già esplorata da sceneggiatrice e attrice in Frances Ha e Mistress America) e quella con la madre (una strepitosa Laurie Metcalf). In attesa di scoprire le sue prossime Cronache di Narnia per Netflix, le sue prime tre opere rivelano una regista in grado di adattare la propria sensibilità ai diversi contesti (il cinema indipendente, il melodramma in costume, la commedia blockbuster), senza mai annullare o nascondere la propria voce.
CHLOÉ ZHAO
vincitrice nel 2021 per Nomadland
A lei e alla collega Emerald Fennell dedicammo il primo numero in assoluto di Singolare femminile, nel 2021: era la prima volta nella Storia che un’edizione degli Oscar vedeva figurare nella cinquina di nominati alla regia addirittura due autrici. Nata in Cina e stabilitasi negli Stati Uniti, anche Zhao è una filmmaker a cui è bastata una manciata di titoli per edificare una cristallina visione d’autrice. E il suo lavoro dialoga, a distanza, con Il potere del cane di Campion (e con altri titoli che non sono arrivati all’attenzione dell’Academy, come First Cow di Kelly Reichardt, American Honey di Andrea Arnold, The Nightingale di Jennifer Kent), partecipando a una riconfigurazione del genere western - classico o contemporaneo -, e di conseguenza del mito americano. Fin dall’esordio con Songs My Brothers Taught Me, e ancora di più con la struggente opera seconda The Rider (forse, a oggi, la sua migliore), Zhao opera sulla prossimità tra fiction, autofiction e cinema del reale, immergendosi in ambienti autentici con occhio e attitudine documentaria e invitando interpreti non protagonisti a rimettersi in scena. Nomadland, tratto da un illuminante libro inchiesta di Jessica Bruder, fa collidere il suo metodo con una grande star hollywoodiana (per quanto anticonvenzionale), Frances McDormand (pure premiata come migliore attrice), e arriva agli Oscar dopo aver vinto il Leone d’oro a Venezia, e una messe di altri premi. Subito fagocitata dalla Disney (che le ha prodotto Nomadland) per il (fallito ma per questo interessante) Marvel movie Eternals, la attendiamo alla prossima prova, nel dramma storico Hamnet, un film sulla moglie di Shakespeare (!), con Paul Mescal e Jessie Buckley.
EMERALD FENNELL
candidata nel 2021 per Una donna promettente
Britannica, nasce come attrice (soprattutto seriale: da Call the Midwife a The Crown, dove ha incarnato Camilla Parker-Bowles) e si sposta dall'altro lato della macchina da presa grazie all'incontro con la mitica Phoebe Waller-Bridge, che le passa il testimone di showrunner per la seconda stagione dell'ottima Killing Eve. Debutta come regista con Una donna promettente, che nel 2021 ottiene, oltre alla nomination per la regia, l'Oscar per la sceneggiatura, ed è subito chiaro che lo sguardo tagliente e provocatorio di Fennell è destinato a lasciare il segno: gioca impunemente coi generi, verga manifesti femministi sulla superficie ludica di un revenge movie rivisitato, trasforma l'(anti)eroina di Carey Mulligan in un'icona di rivendicazioni che sbertuccia il "not all men" travestendosi da infermiera sexy sulle note di Britney Spears. La si ama o la si odia, esattamente come accade con l'opera seconda, Saltburn, satira sensuale che rielabora la tendenza eat the rich in un film a chiave dominato dalla studiata ambiguità del suo protagonista. La si accusa di superficialità e di ipocrisia (proprio da quella classe britannica agiata che mette alla berlina proviene la stessa Fennell), si guarda, per dirla col compianto Lynch, più spesso il buco che la ciambella, e si finisce per trascurare una regista promettente (anche se indubbiamente amante delle controversie: si veda la sua rilettura femminista e woke del musical teatrale Cinderella, un sonoro flop). Vedi newsletter n. 1 e 121
JUSTINE TRIET
candidata nel 2024 per Anatomia di una caduta
Si combattono in spazi convenzionalmente rassicuranti e quotidiani, le battaglie delle protagoniste dei film di Triet: le mura domestiche, la camera da letto, lo studio di una psicoanalista. Dietro, però, c'è sempre un contenitore più grande, una sovrastruttura più ampia che incasella e irreggimenta le vite delle donne, a partire dal suo esordio La bataille de Solférino, dove le schermaglie di una coppia divorziata hanno per sfondo le elezioni presidenziali francesi del 2012, quelle in cui Hollande sconfisse Sarkozy. I film della regista francese hanno spesso per titolo un singolo nome di donna: Sybil, Victoria (da noi, ahimè, Tutti gli uomini di Victoria), a far intendere come le vite, le teste, le identità di queste donne siano un intero mondo, complesso e stratificato, sovente spigoloso e sgradevole, e si specializza in opere che - poco importa che si muovano nella commedia o nel thriller psicologico - esplorano con pervicacia gli anfratti meno "vendibili" e meno appetibili del femminile. L'apice, sinora, di questo percorso è Anatomia di un caduta, Palma d'oro a Cannes 2023 e Oscar per la miglior sceneggiatura nel 2024 (quando Triet è candidata, appunto, anche per la regia), dove lo spazio di battaglia si sposta dalle mura di casa a quelle del tribunale, trasformando l'accusa di uxoricidio rivolta alla protagonista in un processo alla presunta inadeguatezza femminile, alle mancanze che si trasformano in colpe, alle fughe dai lacci che stringono le donne nelle convenzioni sociali. Vedi newsletter n. 17 e 96
CORALIE FARGEAT
candidata nel 2025 per The Substance
In una stagione dei premi, quella in corso, non troppo sfavillante, le cinque nomination per il nostro colpo di fulmine cinematografico del 2024 (fin dalla partecipazione in Concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio alla miglior sceneggiatura) The Substance ci riempiono di gioia: miglior film, miglior attrice protagonista per Demi Moore, miglior sceneggiatura originale, miglior trucco e, felicemente, anche miglior regia per Fargeat. Ci riempiono di gioia non solo per il genere dell’autrice, ma anche per quello del film: sappiamo quanto l’Academy sia allergica all’horror, e The Substance invece abbraccia con entusiasmo la propria discendenza splatter e gore (e anche di commedia, pure un macrogenere che gli Oscar spesso snobbano), aderendo a un filone sempre più proficuo di horror femminista, per mettere in scena una parabola precisa e illuminante sul sessismo, non solo hollywoodiano, e sull’eterna scissione tra essenza e apparenza cui sono costretti da sempre i corpi delle donne. Un progetto che la regista francese ha in cantiere fin dagli esordi, come dimostra il corto Reality+ (disponibile su MUBI e IWONDERFULL), che di The Substance è la prova generale, e che nel folgorante esordio Revenge si esemplifica in un’eroina indimenticabile, che risorge dalle ceneri tra sabbia, fuoco e sangue, per cogliere una catartica vendetta. ALICE CUCCHETTI & ILARIA FEOLE
Lina Wertmüller è scomparsa nel dicembre del 2021: vi riproponiamo il profilo d’autrice, con una riflessione sulla sua eredità, pubblicato su Film Tv n. 50/2021 in quell’occasione.
Da lontano
La notizia della morte di Lina Wertmüller, il 9 dicembre 2021 (aveva 93 anni), mi ha fatto pensare a un passaggio da La macchia umana di Roth, quando si legge di un personaggio femminile, Delphine Roux, e della sua esperienza da insegnante a Yale. «Gli studenti la divertono. Dov’è il loro lato intellettuale? È molto scandalizzata da come si divertono. Che caotico, non ideologico modo di pensare... e di vivere! Non hanno mai visto neanche un film di Kurosawa: sono piuttosto ignoranti. Quando lei aveva la loro età, aveva visto tutti i Kurosawa, tutti i Tarkovskij, tutti i Fellini, tutti gli Antonioni, tutti i Fassbinder, tutti i Wertmüller, tutti i Satyajit Ray, tutti i René Clair, tutti i Wim Wenders, tutti i Truffaut, i Godard, i Chabrol, i Resnais, i Rohmer, i Renoir, mentre l’unica cosa che hanno visto questi ragazzi è Guerre stellari»... Con tutto il rispetto per la Wertmüller (e con tutto l’amore per Roth), mi sono sempre chiesto cosa ci facesse il suo nome in quella lista di giganti del cinema. Lei, che gigante non era, era comunque riuscita a imporsi - anche e soprattutto in quanto donna - come autrice di un cinema riconoscibilissimo, emblema dell’Italia, della sua società piena di conflitti e di contraddizioni, delle sue figure tragicomiche, dei suoi orrori e delle sue miserie. La scorsa settimana Lina Wertmüller è stata giustamente celebrata per il peso soprattutto culturale del suo cinema, lo stesso che Roth inconsapevolmente metteva in luce: chi non conosce, per dire, i duetti fra la Melato e Giannini? E chi non ha mai parodiato almeno una volta uno dei suoi titoli infiniti, iconici quanto e più di una qualsiasi delle sue immagini? I suoi film, però, nonostante i passaggi televisivi dei soliti noti (Mimì metallurgico ferito nell’onore, 1972; Film d’amore e d’anarchia, ovvero stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza..., 1973; Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, 1974; Pasqualino Settebellezze, 1975), oggi rischiano di valere più nel loro insieme, come espressione di una voce inconfondibile degli anni 60 e 70, che singolarmente, come opere indipendenti e di valore. Il cinema della Wertmüller ha dato il meglio nella stagione dell’impegno civile e del privato come trasfigurazione del politico, in quanto riflessione così seria da farsi grottesca quando non surreale, in cui l’immagine distorta del paese finiva per rivelare la vera anima dei suoi abitanti. Lina Wertmüller, però, ammettiamolo con la giusta distanza dovuta ai veri cineasti, non era Marco Ferreri; Travolti da un insolito destino... non è Il seme dell’uomo e Ciao maschio o L’ultima donna non li ha diretti lei. Anche quando faceva di tutto per sembrare uno di quei registi che non credono nelle persone, che fanno film dove un uomo e una donna si odiano e si sbranano su un’isola (cit.), in realtà a interessarle era soprattutto il lato parodico e caotico della sua riflessione. Non il cinismo ma la satira; lo sguardo lungo, sì (a volte pure lunghissimo), ma pure un po’ di accondiscendenza tutta italiana. I suoi film rimangono, e come i loro titoli sono cristallizzati nell’eco di una stagione lontanissima. ROBERTO MANASSERO
In questo numero della newsletter parliamo di registe, ma l’attuale stagione dei premi è contraddistinta soprattutto da una fortissima gara tra attrici, e molte performance meritevoli sono inevitabilmente rimaste fuori dalla cinquina. Tra queste, secondo molti meritava una candidatura Pamela Anderson per The Last Showgirl di Gia Coppola (che da noi uscirà il 13 febbraio): a riguardo vi segnaliamo quest’articolo di IndieWire [in inglese], che mette a confronto la sua performance con quella di Maureen O’Hara nel classico di Dorothy Arzner Balla, ragazza, balla (a proposito: sul numero di Film Tv in edicola c’è un’imperdibile Lost Highway su Arzner, oltre a un approfondimento sull’altra grande esclusa da questi Oscar, Nicole Kidman in Babygirl di Halina Reijn).
Sempre nel numero di Film Tv in edicola dedichiamo l’editoriale a Chantal Akerman, complici la presenza di alcuni suoi film gratuitamente su Arte.Tv e di una retrospettiva organizzata al cinema La Compagnia di Firenze. Segnaliamo che anche l’ultimo numero di “Sight and Sound” è dedicato alla cineasta belga: si può ordinare qui.
Avete smesso di piangere per la morte di David Lynch? Ricominciate pure leggendo la lettera che Laura Dern gli ha dedicato sul “Los Angeles Times”. [in inglese]