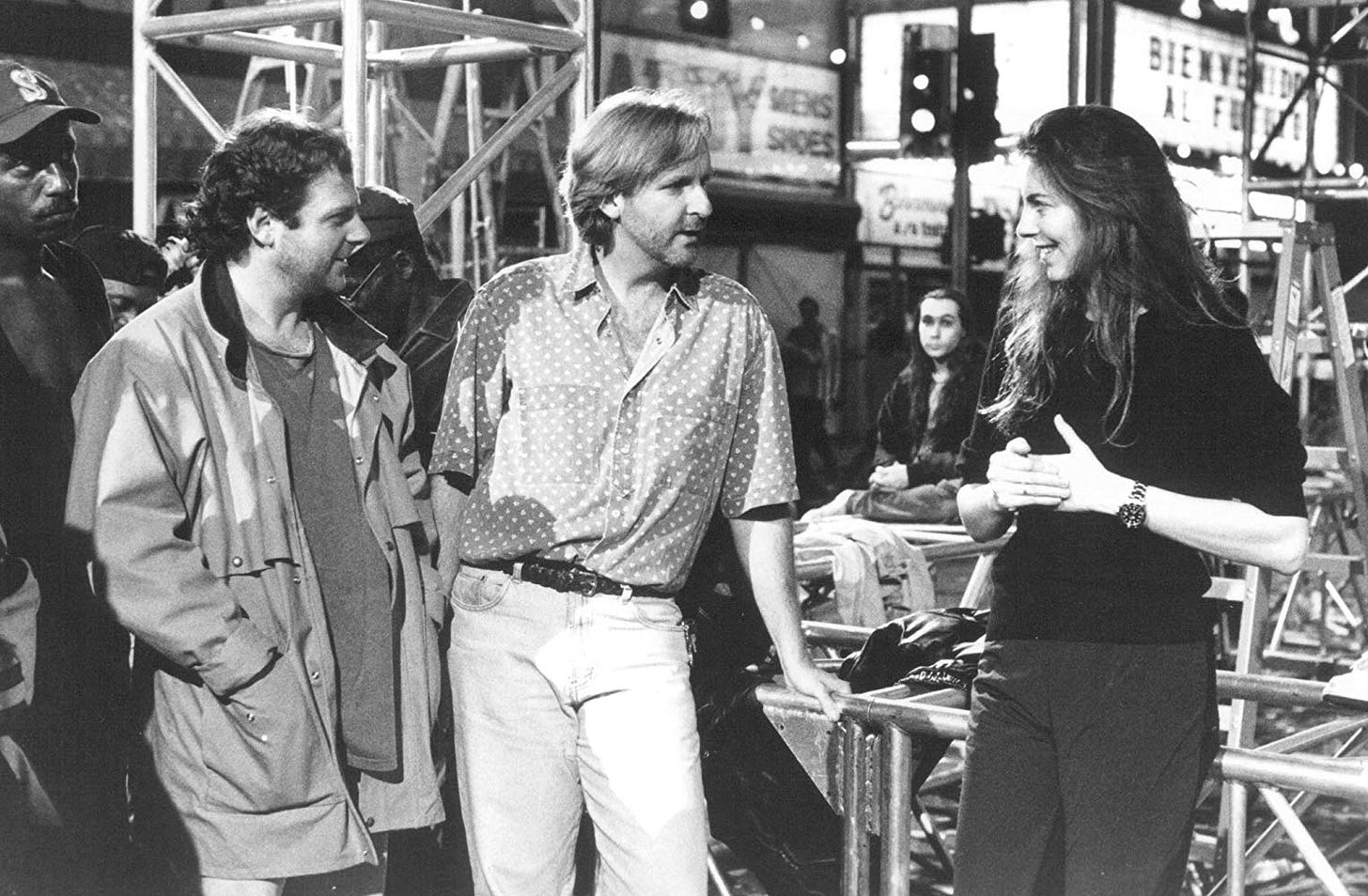Singolare, femminile ♀ #077: Right Here, Right Now
Apocalisse, bugie & MiniDisc: vi auguriamo buone Feste con uno dei migliori “film di Capodanno” di sempre, Strange Days di Kathryn Bigelow, cult movie tra cyberpunk e noir, furia politica e preveggenza, innovazioni tecnologiche e riflessioni metacinematografiche. E vi diamo appuntamento al 2023.
All’uscita in sala, nel 1995, Strange Days di Kathryn Bigelow è un colossale flop al botteghino. Costato la ragguardevolissima cifra di 42 milioni di dollari, ne incassa in tutto circa 8. E nemmeno si può dire che la critica dell’epoca lo abbracci come un capolavoro incompreso: a parte qualche rara eccezione come Roger Ebert, che predice il suo futuro status di cult movie, quasi tutti sono tiepidi o freddi o addirittura ostili (è ancora un periodo in cui bollare un film come “violento” è un efficace marchio d’infamia). Noi italiani abbiamo addirittura uno stroncatore d’eccezione: Nanni Moretti lo mette nel suo Aprile, disperandosi per aver portato il figlio ancora nel grembo materno a vedere una tale porcheria. Come spesso capita (molto più frequentemente alle registe), la carriera di Kathryn Bigelow ne risente moltissimo: ci metterà altri cinque anni per girare il successivo film Il mistero dell’acqua, seguito da K-19 (altre due delusioni al box office), e bisogna arrivare al 2008 di The Hurt Locker, che le consegna l’ambito record di prima donna a vincere un Oscar alla regia, perché venga finalmente riaccolta nel pantheon dei grandi autori.
Il flop di Strange Days arriva inaspettato, perché Bigelow è reduce dal successo di Point Break, lo sceneggiatore e produttore James Cameron da quelli stratosferici di Terminator 2 – Il giorno del giudizio e True Lies, i protagonisti Ralph Fiennes e Angela Bassett dalle candidature all’Oscar rispettivamente per Schindler’s List e Tina – What’s Love Got to Do with It. Ma le reazioni e le ragioni del pubblico sono spesso imperscrutabili; anche perché la rivalutazione di Strange Days – lenta, certo, e comunque “di nicchia” – inizia poi quasi subito. Nel 1999, quando esplode inarrestabile il ciclone Matrix, c’è già chi si ricorda come l’avesse “fatto prima Bigelow!” (oltre all’anime giapponese Ghost in the Shell, sempre del 1995). Di più: a dispetto della tecnologia immediatamente obsoleta attorno cui si organizza la vicenda del film – dei MiniDisc! –, visione dopo visione Strange Days rivela da un lato la preveggenza con cui tratta questioni cruciali del contemporaneo e dall’altro un’anima da vero classico sci-fi (da notare che la parte più esplicitamente fantascientifica dello SQuID, il “caschetto” tentacolare da piazzare sul cranio di chi lo utilizza, è invece un’iconografia “cyborg” ricorrente ancora oggi: un ultimo esempio si trova nella serie Inverso – The Peripheral su Prime Video, tra l’altro tratta da un romanzo del “padre del cyberpunk” William Gibson).
Strange Days è ambientato nel corso degli ultimi due giorni del Secondo millennio, il 30 e 31 dicembre del 1999, tecnicamente dunque in un futuro più che mai prossimo al tempo della sua realizzazione. Il Capodanno s’avvicina pulsando di un sentimento collettivo di apocalisse, e di quello – diffusissimo nei Nineties, per quanto presuntuoso – di “fine della Storia”: «Sai come so che il mondo sta finendo?» blatera il Max di Tom Sizemore in una delle scene iniziali. «Tutto è già stato fatto: ogni genere di musica è stato provato, ogni tipo di governo, ogni taglio di capelli, ogni gusto di chewing gum, ogni tipo di cereali da colazione... Cosa faremo? Come possiamo tirare avanti un altro migliaio d’anni? Te lo dico io, è finita. Abbiamo finito tutto quanto». Ma non è davvero un futuro quello abitato dai personaggi di Strange Days, bensì un passato trascorso da pochissimo e ancora vivido nella memoria di chi l’ha attraversato, quello dei riot di Los Angeles del 1992, seguiti al brutale pestaggio del tassista Rodney King, filmato da una videocamera amatoriale e diffuso su tutti gli schermi del globo, e all’inaccettabile assoluzione degli agenti della polizia che l’avevano perpetrato. La città che attraversano Lenny e Mace, obbligatoriamente protetti dall’involucro dell’automobile, è una metropoli contemporaneamente “senza regole” (in una delle prime scene, Lenny vede due ragazze inseguire un Babbo Natale per strada e prenderlo a pugni per derubarlo) e iper militarizzata, con le onnipresenti forze di polizia in assetto da guerra, con tanto di carri armati (uno scenario in cui davvero si trasformò la Città degli angeli nel 1992, e quasi trent’anni dopo lo stesso capitò alle moltissime aree urbane statunitensi agitate dalle proteste per l’uccisione di George Floyd).
L’idea base di Strange Days, la tecnologia che permette di registrare e letteralmente rivivere pezzi di vita propri e altrui attraverso un device elettrico (lo SQuID, appunto: Superconduting Quantum Interference Device), discende direttamente dalla fantascienza filosofico-sociale di Philip K. Dick (la similitudine più immediata è Ricordiamo per voi, il racconto da cui è tratto Total Recall – Atto di forza) e prospera nel filone cyberpunk fiorito nei primi anni 80, tra la realizzazione di Blade Runner di Ridley Scott (1982, sempre da Dick) e la pubblicazione di Neuromante di William Gibson (1984), testo seminale e fondativo di un immaginario distopico che entra all’istante nella consapevolezza collettiva. È proprio negli anni 80 (pare tra il 1985 e il 1986) che James Cameron inizia a cullare il soggetto che sarà alla base di Strange Days (inizialmente intitolato The Magic Man, cioè il modo in cui il protagonista Lenny Nero chiama se stesso quando cerca di sedurre potenziali clienti), ma è solo quando ne parla per la prima volta a Kathryn Bigelow – i due sono sposati tra il 1989 e il 1991 – che il progetto comincia a prendere una vera forma. E sono poi le rivolte di Los Angeles nel 1992 a fare da catalizzatore finale, soprattutto per Bigelow: mentre Cameron si concentra sull’intreccio poliziesco e sul triangolo d’amore non corrisposto tra Mace, Lenny e Faith, l’autrice californiana insiste soprattutto sul versante politico della vicenda, sulla restituzione della violenza che scorre sotto la pelle d’asfalto della città e sul collegamento diretto ed evidente – ma non didascalico – con i fatti del 1992.
È proprio la tecnologia immaginata da Cameron, uno strumento che origina registrazioni ininterrotte in soggettiva della realtà, a permettere a Bigelow di collegare un contesto apocalittico ambientato un attimo prima del crollo della civiltà (e non dopo), portato al limite dall’ingiustizia sociale, a quanto avvenuto con il caso di Rodney King qualche anno prima dell’uscita del film. La videoregistrazione diffusa (e nascosta) e in prima persona diventa un modo di riflettere sulle potenzialità, i significati molteplici, gli effetti di questo tipo di immagini, quasi che la regista avesse potuto saltare su una macchina del tempo per visitare il nostro presente e scoprirlo dominato da un flusso continuo di registrazione e trasmissione del sé, tra i feed di Instagram e le Stories, le live sui social e gli algoritmi di TikTok, noi tutti contemporaneamente autori e pubblico, intenti a consumare frammenti di vita e memorie nostre e altrui. Strange Days mette al centro sia della sua trama gialla sia del suo discorso politico una clip che testimonia un crimine intollerabile e che può contenere in sé la definitiva scintilla della rivolta. E allo stesso tempo rappresenta un panorama in cui le registrazioni dei ricordi – propri o di altri – sono una droga in cui si annega, il passato tanto più vivido e desiderabile del presente da dare dipendenza. E la tecnologia SQuID, che permette di indossare letteralmente emozioni, sensazioni, pezzi di vita altrui è insieme una potente macchina d’empatia e un nuovo meccanismo di sfruttamento.
Come conferma Bigelow anche nelle interviste, è proprio la riflessione su questa natura molteplice e contraddittoria dell’immagine a interessarla maggiormente, oltre alla questione razziale (su cui tornerà, più di vent’anni dopo, con il controverso Detroit), e al modo in cui i due aspetti possono essere collegati. Vede Lenny Nero come un regista-sceneggiatore dei desideri altrui, e la storia che ci racconta come una riflessione sul voyeurismo, sull’impossibilità di ogni immagine filmata di non farsi spettacolo, e dunque di essere un vettore di exploitation (non a caso, in Strange Days, sono tutti paranoici. Anzi, il commentatore designato Max lo esplicita con una battuta diventata celebre: «Il punto non è se sei paranoico, Lenny, il punto è se sei paranoico abbastanza»).
È affascinante e forse perfino paradossale che, per realizzare Strange Days, Bigelow debba inventarsi, insieme al suo direttore della fotografia Matthew F. Leonetti, una camera apposita, una sorta di ibrido tra una steadicam e una camera a mano, in grado di riprodurre il più da vicino possibile l’esperienza di visione di un occhio umano (e qualcosa di maledettamente simile alle camere dei nostri odierni smartphone). In questo modo, quando qualcuno nel film si collega allo SQuID e rivive un ricordo altrui, anche noi facciamo lo stesso: siamo costretti nel ruolo di complici, obbligati a compartecipare allo sfruttamento, alimentandolo. Un circolo trasformato in tortura dal killer al centro del film, che fa indossare alle proprie vittime lo SQuID mentre le uccide, obbligandole a vivere contemporaneamente anche l’esperienza del carnefice: l’etichetta di “film violento” deriva da queste sequenze, in cui di davvero esplicitamente crudo o gore non si vede praticamente nulla. È la violenza psicologica a essere insostenibile, e il fatto che lo spettatore sia forzato a viverla nei panni dell’assassino (nel film è presente una scena di stupro molto criticata, anche da alcune femministe: ma è in realtà proprio il suo esser filmata in modo asettico e senza stacchi a renderla, contemporaneamente, insostenibile e priva di ogni sensazionalismo).
Ma Strange Days, naturalmente, non è solo teoria e metacinema. È soprattutto, come sempre con Bigelow, e particolarmente in questa sua prima fase di carriera, un grande film di genere, anzi di generi: ne contiene molti e sa fonderli con fluidità distillandone formule nuove (come già nel bellissimo e struggente western vampiresco Il buio si avvicina). Strange Days è science-fiction cyberpunk, è un thriller d’azione, è un mistero giallo, ma è anche, moltissimo, un noir, con il più archetipico degli antieroi – Lenny, ex poliziotto congedato con disonore e diventato spacciatore (di SQuID), consumato da un passato perduto e dall’ossessione per un amore irrecuperabile – e la più seducente e pericolosa delle femme fatale – Faith, una giovane e sinuosa Juliette Lewis, inguainata in miniabiti di lustrini di cui è impossibile individuare i contorni, ipnotica mentre urla PJ Harvey con la rabbia di un animale in gabbia. Michael Wincott (che quest’anno abbiamo ritrovato in Nope di Jordan Peele, un film che tra l’altro nella riflessione su videoregistrazione e spettacolo condivide moltissimo con Strange Days) aggiunge un altro volto alla sua memorabile galleria di villain anni 90 – anche se a fare più paura di tutti è Vincent D’Onofrio che fa quella faccia –, ma il vero cuore pulsante del film è indubbiamente Angela Bassett nel ruolo di Mace, migliore amica di Lenny (e innamorata di lui), autista di limousine, occasionale guardia del corpo, generalmente impegnata a tirare fuori il protagonista dai vicoli ciechi in cui va a ficcarsi.
Mace s’inserisce nella tradizione delle eroine cameroniane (una sua erede più giovane, anche perché in un simile contesto cyberpunk, sarà la Max/Jessica Alba della serie Dark Angel), strong female character in cui convivono determinazione e vulnerabilità, e alle quali l’autore affida il ruolo “eroico” di salvatrici tradizionalmente (soprattutto nel cinema di genere) designato per i personaggi maschili. Nel rapporto tra Lenny e Mace quest’inversione del canone è evidente, con le ottime prove dei due attori a riempire di sfumature ogni possibile manicheismo: il primo è, fisicamente ma pure moralmente, debole, fino a sfiorare il patetico; la seconda è forte, competente, decisa, piena di risorse, ed è pure l’evidente centro morale del film. A lei è affidato uno dei monologhi più celebri, quello sulle memorie a cui dev’essere concesso di sbiadire per evitare di attraversare come fantasmi o zombie il proprio presente, per essere davvero vivi «right here right now» (il campionamento di questa battuta diventerà la base dell’omonima canzone di Fatboy Slim). Ed è infatti attraverso di lei che deve passare la visione/esperienza della fondamentale clip di Jeriko One, come se fossero i suoi occhi e la sua pelle (quelli, tra l’altro, di una donna nera) a certificare la legittimazione politica di quelle immagini rubate (Bigelow nota, tra l’altro, che tutti i suoi personaggi sono costretti a un certo punto a sprofondare nel proprio lato oscuro per poi riemergerne: per Mace, che si è sempre rifiutata categoricamente di farlo, significa cedere e provare lo SQuID). Ed è il corpo di Mace malmenato da un branco di poliziotti nel finale che richiama direttamente Rodney King, accende la miccia della rivoluzione, si fa portatore di un’unica flebile possibilità di speranza.
Nel finale di Strange Days scocca la mezzanotte e il cambio di millennio, nel pieno di un rave – organizzato davvero, a downtown Los Angeles, con gli Skunk Anansie a suonare dal vivo sul palco e migliaia di comparse a festeggiare per le strade – e in una pioggia di coriandoli colorati. A Lenny e Mace tocca perfino un inaspettato lieto fine, uno degli aspetti del film più criticati, talvolta perfino dai suoi difensori: da dove viene quest’improvvisa luce, in questo scenario distopico tanto cupo e rassegnato? Eppure per tutto il film Kathryn Bigelow ci ha mostrato, sottilmente, l’ambivalenza delle immagini, il loro potenziale insieme distruttivo e generativo. Viene dal cinema, allora, quel bacio travolgente in mezzo alla folla e alla festa, in un turbinio di colori e luci – e dalla speranza testarda che agli eroi ed eroine di Bigelow non manca quasi mai.
ALICE CUCCHETTI
In occasione di quello che, al momento, è ancora l’ultimo film di Kathryn Bigelow, Detroit, pubblicavamo su Film Tv n. 47/2017 uno speciale e una “lettera d’amore” alla regista firmata da Mariuccia Ciotta. Ve la riproponiamo.
Lettera da una sconosciuta - Punto di rottura
Bigelow cara, algida presenza di star, perfetta silhouette levigata... I ricordi provenienti da Riminicinema 1996, un brindisi insieme per il premio Fellini, mi consigliano una certa distanza iniziale. Non si chiama per nome un cyborg, se non dopo averne analizzato la percentuale di materia organica. Già, perché eri corpo cangiante, androgino e così immateriale da sembrare aliena, o meglio un’evoluzione della specie, carne e macchina. Realizzazione dei progetti post-umani più ambiziosi, tanto che sentir dire «è la prima donna a vincere l’Oscar» suona un po’ stravagante, vista la tua estraneità alle convenzioni di genere. Il tuo cinema si specchia in questa metamorfosi totale, e fa da apripista a un passato che annovera molte cineaste cancellate da piccoli spazzini dell’immaginario. La “prima donna”, sì, nel senso dell’incedere nobile tra il sangue e le bombe di The Hurt Locker, guerra piangente e corpi esplosivi. Come minare l’immaginario bellico. E prima, agli esordi, la sorpresa ipercinetica e seriale di The Loveless, custodito al MoMA di New York, risultato della frequentazione con l’avanguardia artistica. Sullo split screen corrono liberi i motociclisti in stile Willem Dafoe. Rivelazione. E poi l’adorazione di massa per Point Break, ancora maschi dai contorni vellutati, Keanu Reeves, erotismo acquatico e ambiguo. Il massimo della forza bruta, però, l’hai riservato alla rossa, disorientata Jessica Chastain, agente della CIA in Zero Dark Thirty, osservatrice di tanti Abu Ghraib, spettacolo ripugnante ma necessario, sembra. La colpa, però, fu tutta di Bin Laden, che sconvolse il copione del film quando si fece ammazzare in diretta. Tornando indietro nel tempo, prima di un’altra prova muscolare, K-19 con Harrison Ford, sono rimasta folgorata da Strange Days, orchestrato insieme a James Cameron, travolgente nel delirio di un futuro concreto e vicino. Indimenticabile il software quantico, la coroncina digitale che fa vivere esperienze al limite. Come Detroit, viaggio temporale a bordo del Superconducting Quantum Interference Device, lo SQuID. Lì, tutti noi, sbattuti al muro da psicopatici poliziotti durante la rivolta black nel luglio del 1967. Niente affatto oggetti di sevizie, ma attivisti di un mondo giusto bianco/nero contrapposto agli scarti del potere in divisa.Vittoria. Cara Kathryn, l’amore per quel cinema che promette “tutto è possibile” a noi orfani della rivoluzione, parole di Alain Badiou, ti riguarda. Contro le regole del thriller, in Blue Steel - Bersaglio mortale Jamie Lee Curtis avanza sonnambula per le strade di Manhattan, alle prese con un fantasma armato della celebre 44 Magnum, protesi fallica e molesta sgominata da una calibro 38. Ti dirò, dunque, che l’intensità emotiva la concentro nelle tue note a margine, fotogrammi e film, in particolare nel titolo quasi dimenticato del 1987, Il buio si avvicina, dove i divanetti imbottiti di una tavola calda del Sudovest americano grondano liquido rosso, e non è ketchup, e dove l’elegante Dracula rivive in una scalcinata motorcycle gang più crudele dei Vampires di Carpenter. Ancora contro il “genere”, Mae, la vampiretta adolescente, si svena per nutrire Caleb, il ragazzo di campagna innamorato, e la contaminazione di sangue cambia il finale della coppia incompatibile di Shakespeare. Umano e disumana in simbiosi. Era già sulle strade bruciate dal sole che incenerisce i mostri il tuo cinema saturo di violenza necessaria. Mi piace l’happy end che segue alle tue catastrofi, anche quando ogni speranza è perduta e gli spettri volteggiano sulla storia. Fuori campo c’è sempre un finale felice. Tutto è possibile. Ed è per questo che dobbiamo amarti.
MARIUCCIA CIOTTA
Se siete in cerca di un suggerimento per un regalo di Natale dell’ultimo minuto, è da poco stato pubblicato Mia madre ride di Chantal Akerman, cineasta il cui Jeanne Dielman è stato da poco incoronato miglior film di sempre dalla rivista “Sight and Sound” (ne abbiamo parlato sulla newsletter n. 75 e sul n. 50/2022 di Film Tv). Qui potete leggerne un estratto.
Sul “New York Times” un articolo prezioso: la storia di quella che potrebbe essere la prima animatrice della storia, Bessie Mae Kelley, attiva fin dalla metà degli anni 10 del Novecento ma “dimenticata” dagli storici, e del lungo lavoro della studiosa Mindy Johnson per riportarne alla luce la memoria [in inglese].
Se siete invece in cerca di qualcosa da ascoltare durante le Feste, potete recuperare sulle varie piattaforme dedicate il podcast Giornaliste, prodotto da Storielibere.fm e dal Circolo dei lettori, in cui reporter e scrittrici di oggi raccontano quelle di ieri (tra le altre: Susan Sontag, Dorothy Parker, Alba de Cespedes, Gerda Taro…) e il modo in cui hanno cambiato la storia dell’informazione.
Singolare, femminile vi augura buone Feste, si prende una pausa e vi dà appuntamento a mercoledì 11 gennaio con il primo numero del 2023. Auguri!