Singolare, femminile ♀ #040: Un’invisibile bellezza selvaggia

Singolare, femminile
lo schermo delle donne
- di Alice Cucchetti e Ilaria Feole -
#040 - Un’invisibile bellezza selvaggia
Ciao ,
questa è Singolare, femminile, un viaggio settimanale attraverso i film, le serie televisive, le autrici, le attrici che hanno fatto e stanno facendo la storia del cinema e della tv.
***
Su MUBI è arrivato Cow, l’ultimo lungometraggio della cineasta britannica Andrea Arnold. Un’autrice che fin dai primi cortometraggi – anch’essi disponibili sulla piattaforma – ha illuminato un rispecchiamento tra la natura umana e quella selvaggia, fotografando sistemi sociali violenti e cercando per le sue protagoniste vie di fuga e di libertà.

Può sembrare un piccolo film, Cow di Andrea Arnold, documentario (distribuito da MUBI) che per una novantina di minuti insegue l’esistenza rutinaria e sfiancante di Luma, una mucca da latte in una fattoria intensiva inglese. La camera agganciata al suo punto di vista, un tappeto sonoro fatto di rumori di fondo, la presenza umana sempre sfocata e lontana, a un’occhiata distratta sembra distante dai precedenti – sempre umanissimi – progetti dell’autrice, e in particolar modo dai suoi lavori dell’ultimo quinquennio o poco più, come regista di prestigiose serie tv statunitensi (Transparent, I Love Dick e Big Little Lies – in quest’ultimo caso, va ricordato che la produzione HBO ha rimosso Arnold dal controllo creativo in fase di post produzione, rimontando il suo girato e aggiungendo nuove sequenze). In realtà Cow è stato in lavorazione per ben otto anni, di cui quattro di riprese: quasi un piccolo Boyhood, come ha ammesso la stessa autrice in diverse interviste, raccontando di averlo filmato nel corso del tempo e nel mezzo di altri progetti, recandosi alla fattoria sia quando qualcosa d’importante stava per accadere nella vita di Luma (un parto, una monta, la fine) sia di tanto in tanto per catturare semplici istanti della sua quotidianità.

E pur nella sua radicalità antispecista, determinata ad adottare la prospettiva animale dall’inizio alla fine, in realtà Cow è perfettamente coerente con il percorso d’autrice di Arnold, e conserva tutte le marche del suo stile. Basterebbero forse anche solo i titoli dei suoi primi tre lavori dietro la macchina da presa (Arnold in gioventù è stata ballerina e attrice, e per tutti gli anni 80 e parte dei 90 ha lavorato a programmi per bambini per la tv britannica): i tre cortometraggi che MUBI ha pubblicato insieme a Cow, l’esordio del 1998 Milk, il successivo Dog del 2001 e Wasp, del 2003, vincitore addirittura dell’Oscar per il miglior film breve di finzione. Come sempre in Arnold la sessualità è un motore ineludibile fino a farsi disturbante, e il confine tra umanità e bestialità s’intreccia, si assottiglia, spesso si annulla: in Dog c’è l’esempio più letterale, in cui a un imperdonabile atto di crudeltà su un cane segue una sorta di “mutazione” della protagonista, che reagisce all’ennesima violenza subita abbaiando come il cucciolo morente. In Wasp, su una vespa che entra ed esce da un piccolo corpo sono costruiti il climax e la catarsi finale, chiudendo un limpido cerchio di sceneggiatura che illumina un altro dei temi prediletti da Arnold: la prigionia (e, di conseguenza, la libertà).

Come la vespa “scacciata” (liberata?) dalla protagonista di Wasp, il cinema di Arnold è pieno d’insetti che si dibattono contro vetri chiusi, porte, superfici o pareti: sono immagini particolarmente ricorrenti in American Honey, il penultimo lungometraggio della cineasta, nonché il suo primo film statunitense, ma non mancano quasi mai anche nei suoi altri progetti. Arnold è un’osservatrice di sistemi violenti: può ingannare, a prima vista, con un’immersione spesso contemplativa, e perfino dolciastra, negli elementi naturali, con un avvolgente senso quasi impulsivo del ritmo, dell’inquadratura, dei movimenti della macchina a mano che finisce per evocare immagini vivide e spesso bellissime, nonostante il presunto squallore di molti suoi soggetti. Anche descrivendo Cow dice di cercare, con l’obiettivo della camera, l’«invisibile bellezza selvaggia» delle cose; di tutte le cose, anche dell’impianto di sfruttamento di un allevamento intensivo, anche dei casermoni popolari della periferia di Londra nei quali è cresciuta (e che, davanti alle sue prime prove – Dog, Wasp, Red Road, Fish Tank – avevano chiamato parallelismi con il cinema di Ken Loach).

Nata nel 1961 da una madre sedicenne, prima di quattro fratelli e sorelle, è cresciuta in un contesto non dissimile da quelli immortalati in Wasp e soprattutto in Fish Tank, il suo film maggiormente autobiografico (premiato a Cannes con il Gran premio della giuria, che Arnold ha ricevuto anche per Red Road e American Honey: condivide il record di tre vittorie con, guarda caso, Ken Loach). E che infatti s’intitola “acquario” e ha di nuovo per protagonista una ragazza “imprigionata”: l’adolescente Mia, che sogna la fuga allenandosi, nei solitari stanzoni di palazzoni disabitati, per un talent show di danza che poi si rivelerà essere un deludente vicolo cieco (così come il nuovo compagno della madre, incestuosa figura paterna). In Fish Tank, come poi in American Honey, l’autrice affida il film a un’attrice non professionista, alla prima esperienza: la giovanissima Katie Jarvis, furiosa e magnetica, è stata scelta dopo aver assistito a una sua lite col fidanzato sulla banchina di una stazione, e come tutte le protagoniste di Arnold è un incendio inestinguibile di istintualità e rabbia, sempre sull’orlo di una deflagrazione (anche, naturalmente, sessuale).

Lo stesso miracolo si ripete con American Honey, la cui interprete principale, Sasha Lane (oggi un’attrice affermata, la vedremo presto nell’adattamento seriale di Parlarne tra amici di Sally Rooney), è stata avvicinata dalla regista e dalla sua direttrice di casting mentre era con degli amici su una spiaggia, durante uno spring break. Se si eccettuano Shia LaBeouf e Riley Keough, praticamente tutti gli altri interpreti di American Honey sono non professionisti, spesso pescati tra quelle stesse mag crew al centro del film, piccole comunità di giovani homeless che attraversano l’America cercando di vendere porta a porta abbonamenti a giornali, in cambio di una percentuale risibile con cui si mantengono a fatica. La libertà della macchina da presa (per Arnold imprescindibile, al punto che rifiuta categoricamente di coreografare le scene prima di girarle) si somma a quella di una recitazione più che mai naturalistica, frutto del contesto più che di un’accurata preparazione: i confini tra documentario e fiction, ancora una volta, si perdono, in favore di un’esperienza sensoriale che lascia emergere quella famosa “invisibile bellezza selvaggia”, spesso rintracciata in luoghi di desolazione («I found love in a hopeless place» è il verso di Rihanna che risuona nelle corsie di un supermarket all’inizio di American Honey e che dà il via all’avventura della protagonista Star).

Avviene anche in un’opera sulla carta più “canonica”, addirittura un adattamento letterario, e di un capolavoro del romanticismo gotico come Cime tempestose di Emily Brontë: il suo Wuthering Heights (di cui Arnold sceglie di trasporre, intelligentemente, solo la prima parte, focalizzandosi soprattutto sull’adolescenza di Catherine e Heathcliff), i dialoghi ridotti al minimo, la musica assente, la colonna sonora fatta di colpi, cigolii e vento, è un’altra esperienza immersiva nella natura selvaggia della brughiera, e l’amore tra i protagonisti è fatto di umori e fango, di insetti (ancora una volta) e sangue, di versi animaleschi e tempesta. Qui e in American Honey Arnold sceglie il formato 4:3, in apparente antitesi con la sua ansia di liberazione, ma in realtà perfettamente funzionale a rimarcare come, ancora una volta, i personaggi siano stretti in un sistema di sopraffazione: anche la scelta (dai soliti noti stupidamente contestata) di un attore nero per Heathcliff (assolutamente non in contraddizione con il romanzo, tra l’altro) esplicita che il cuore di questo immortale melodramma sta tutto in un’organizzazione sociale ingiusta, in una violenza di razza e classe.

Quello di Arnold è un cinema liberissimo, e pieno di prigioni: già la protagonista di Red Road (l’esordio nel lungometraggio, nato da un progetto Dogma 95 mai ultimato, che prevedeva che tre registi realizzassero tre film diversi con gli stessi personaggi e attori) osservava ossessivamente le telecamere a circuito chiuso di un altro complesso di case popolari, e s’infilava in una trappola di seduzione e vendetta; Fish Tank, Wuthering Heights e American Honey sono tutte storie di fughe (im)possibili, punteggiate di immagini che evocano sbarre, ostacoli, inscatolamenti, chiusure; e infine c’è la Luma di Cow, la prigioniera più letterale di tutte, ingabbiata in un ciclo forzato di gravidanze e parti, in percorsi ripetitivi e obbligati da recinti e spintoni, nell’ottimizzazione dello sfruttamento del suo corpo e delle sue funzioni vitali e riproduttive. La sfida – vinta – di Andrea Arnold è quella di restituirci il suo punto di vista, standole a fianco con la camera operata dalla direttrice della fotografia Magda Kowaczyk (che sostituisce qui il suo DOP abituale Robbie Ryan), una visione vicinissima e inevitabilmente parziale, più volte sballottata nello scontro con altre mucche o con l’uomo, proprio come accade ogni giorno a Luma.

È certo un film (come sempre più titoli in questi ultimi anni di nuova consapevolezza sulla crisi climatica) che prova testardamente ad abbandonare la prospettiva antropocentrica, ad abbracciare un margine che è insieme alieno e intimo. Oltre all’ambientalismo e alle filosofie antispeciste, però, in Cow Arnold fa un passo ulteriore nel rispecchiamento tra umano e bestiale di molte delle sue protagoniste precedenti (oltre ai già citati Wasp e Dog, pensiamo anche, per esempio, al confronto tra Star e il grizzly in American Honey e al tentativo di liberazione del cavallo di Mia in Fish Tank). Ridotta a una routine di sola produttività, con l’unico commento malinconico e straordinariamente appropriato di canzoni pop (il commento musicale in Arnold è quasi sempre intradiegetico, e qui il primo brano che sentiamo è Lovely di Billie Eilish e Khalid: «Oh I hope some day I’ll make out of here/Even if it takes a night or a hundred years/Need a place to hide but I can’t find one near/Wanna feel alive, outside I can’t fight my fears»), Luma assapora la felicità nei pochi e illusori scampoli di libertà che le vengono concessi, brucando sotto un cielo denso di nuvole veloci, o fitto di stelle luminose. La sua quotidianità interroga direttamente (e politicamente) la nostra, il suo sistema normalmente spietato riflette i nostri apparati di regolare sfruttamento e metodica ingiustizia. E le vie di fuga, i bivi davanti ai quali talvolta Luma s’incaglia, il suo sguardo colmo d’invisibile bellezza selvaggia sono lì a offrirci, come uno spiraglio di luce, un atto in potenza di disperata speranza. ALICE CUCCHETTI
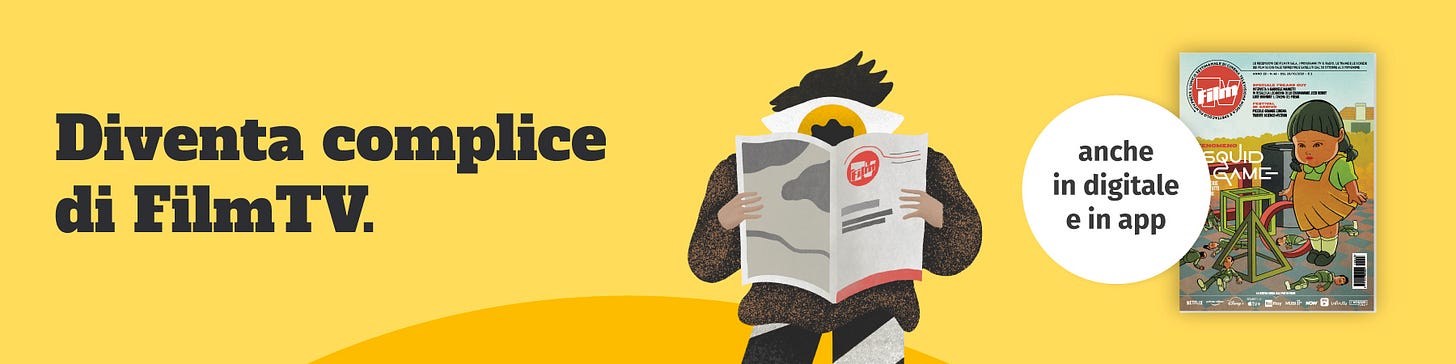

A parte l’esperienza “a metà” di Big Little Lies, le regie televisive di Andrea Arnold nascono dalla collaborazione con Joey Soloway, per cui ha firmato tre episodi di Transparent (uno a stagione, dalla seconda alla quarta) e la maggioranza delle puntate di I Love Dick, serie tratta dall’omonimo memoir di Chris Kraus e interpretata da una superba Kathryn Hahn. Ve ne riproponiamo la recensione. Entrambe le serie sono su Amazon Prime Video.

I Love Dick
Dick entra in città a cavallo, uno Stetson sul capo, gli stivali da cowboy. Dick, nel bel mezzo del Texas, possiede un ranch, ma anche un istituto d’arte, con annessa struttura accademica che offre borse di studio a personalità brillanti e meritevoli. Dick è un genio, universalmente acclamato: le sue sculture fendono orizzontali il deserto e sfidano verticali il cielo, geometrie prepotentemente lineari, materiali densi, scuri, pesanti, un succedersi di simboli inevitabilmente fallici. Dick è figo, non c’è altro modo per dirlo: incede con la sicurezza di chi sa che il mondo non solo gli appartiene ma addirittura si genera alla sua presenza, e infatti è successo proprio questo alla cittadina di Marfa, isola di creatività, un po’ hippie un po’ hipster, nel cuore del nulla. Chris non è figa, invece: sui 40, sposata col più anziano Sylvere (a Marfa, inizialmente, la chiamano “la moglie dell’Olocausto”, campo di ricerca del marito), filmmaker di scarso successo, goffa e insoddisfatta, fallimentare. Insopportabile. I Love Dick è la sua storia, la «storia di una donna che si odia e nel frattempo cerca di diventare se stessa». Chris e la sua storia non sono belle da guardare, non sono carine, bensì indecenti: appena posa gli occhi su Dick (che in inglese sta anche per “pene”, ça va sans dire), s’impossessa di lei un sentimento violentissimo che è insieme desiderio sessuale ed estasi artistica. «Caro Dick»: iniziano così le mille lettere di Chris, che dallo schermo ci aggrediscono bianche, a caratteri cubitali, su sfondo rosso, e che, inarrestabili e incontenibili, esondano, sotterrano Dick, e Sylvere, e Marfa, e i suoi abitanti, dando la stura a un vortice anarchico di creatività che manda in frantumi ogni linea retta. «Che c’è, non ti piace essere una musa?» butta lì un disperato Sylvere all’impotente Dick, che dall’ossessione tumultuosa di questa donna disastrosa si sente «umiliato». Forse perché “musa”, al maschile, non esiste. Dall’omonimo romanzo memoir di Chris Kraus (Neri Pozza), Jill Soloway (Transparent) e Sarah Gubbins traggono un oggetto imprendibile, divertentissimo e intelligente, che si preoccupa di molte cose - il sesso, il matrimonio, i rapporti tra i generi, la cultura, l’arte - e riesce a dirle, in modo intenso e inaspettato, facendone soprattutto una questione di sguardo: provando a sovvertire la relazione tra chi osserva e chi è osservato, che è da sempre, prima di tutto, un fatto di potere. Quello di I Love Dick è uno “sguardo femminile”, soprattutto nella misura in cui s’interroga sul senso stesso di questo concetto, e cerca d’esprimersi, di conquistarsi spazi, di liberarsi, a qualunque costo. Quattro episodi li dirige Andrea Arnold, due la co-creatrice Soloway, uno Kimberly Peirce e uno il direttore della fotografia Jim Frohna (non a caso, pensiamo, quello in cui Sylvere e Dick fanno quattro chiacchiere): nel loro Texas selvaggio, innaffiato di musica e spazzato dal vento, distillato in fermo-immagini disorientanti, si cela un’esperienza viscerale, decisa a ritrovarsi prima che a farsi trovare. Per poi prendere alle spalle, dichiarando, sfrontatamente: «Non siamo lontane dalla vostra porta di casa».
ALICE CUCCHETTI

Si è conclusa la Berlinale 2022, e l’Orso d’oro è andato ad Alcarràs della regista spagnola Carla Simon. Nel Palmarès anche la grande Claire Denis, Orso d’argento per la miglior regia a Avec amour et acharnement, Natalia Lopez Gallardo col Premio della giuria per Robe of Gems e la sceneggiatrice Laila Stieler per lo script di Rabiye Kurnal vs George W. Bush. A una regista, Anastasia Veber, anche l’Orso d’oro per il miglior corto, Trap, mentre l’Orso alla carriera, quest’anno, è stato assegnato alla meravigliosa Isabelle Huppert. Su FilmTv.it le nostre recensioni dalla Berlinale.
È in libreria da qualche giorno un libro cui teniamo molto, Lo spazio delle donne di Daniela Brogi, edito da Einaudi. Contiamo di parlarvene presto. E, sempre a proposito di libri, esce oggi, 23 febbraio, Monica Vitti, una biografia della grande diva recentemente scomparsa scritta da Cristina Borsatti per Giunti.
Sempre oggi, 23 febbraio, arriva in sala Il mondo a scatti, l’ultimo film realizzato prima della morte da Cecilia Mangini, insieme a Paolo Pisanelli. Un’opera che mostra il poderoso lavoro sulle immagini della straordinaria documentarista, dal Dopoguerra al nuovo millennio, punteggiato d’incontri straordinari con, tra gli altri, Pier Paolo Pasolini e Agnès Varda.

Ci vediamo la settimana prossima con Singolare, femminile! Se ci vuoi segnalare qualcosa oppure semplicemente lasciare un messaggio relativo a questa newsletter, puoi scriverci all'indirizzo info@filmtv.press. Ciao e buon anno!
Se Singolare, femminile ti è piaciuta, inoltra la mail a qualcuno che possa essere interessato, è facile, ci si iscrive a questo indirizzo. Grazie!


